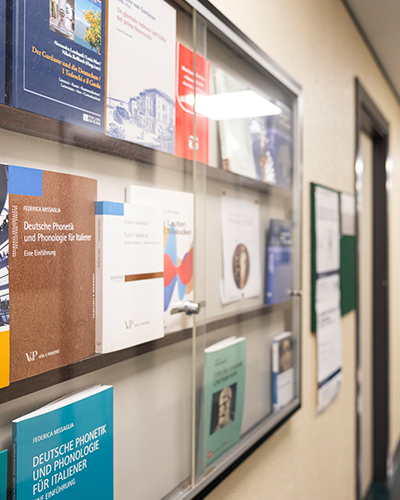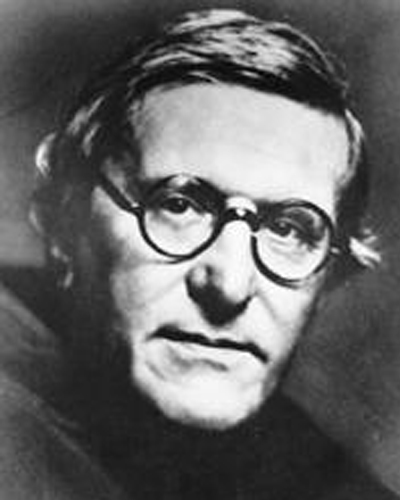News
5 elementi trovati
-
Convegno (IDEO, Cairo) -
L’Università Cattolica nel progetto europeo TransatlanticLab
03 luglio 2025 -
Nuovo volume della Collana del Dipartimento
23 maggio 2025 -
Premio Pubblicazioni di Alta qualità - Benedetta Belloni e Valentina Morgana
03 marzo 2025 -
Maria Teresa Zanola Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques
03 marzo 2025